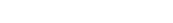Smascherare le Fake News con il Fact Checking funziona davvero?
Al fine di smascherare le Fake News si tende sempre più spesso a far ricorso ad una pratica diffusa sul web, nota come "fact checking", vale a dire una verifica basata sulla ricerca di "fatti" (e più spesso sui dati) reperibili pubblicamente (soprattutto in rete) che smentiscano le tesi e le notizie diffuse con le Fake News.
Tale approccio, seppur meritorio, rischia tuttavia di avere alcune controindicazioni di principio (oltre che pratiche) non trascurabili.
Dal punto di vista "di principio", il fact checking tende a suffragare (e a basarsi sulla) la "Teoria della Verità Manifesta", vale a dire la teoria secondo la quale la verità dei fatti non ha bisogno di essere argomentata criticamente, essendo sufficiente un approccio "trasparente" ai fatti stessi, per farne emergere "spontaneamente" la loro veridicità.
Fact checking, i dati non parlano da soli
È l'approccio tipico di chi sostiene che "i dati parlano da soli", e che ogni forma di interpretazione dei dati sia in quanto tale "sospetta" (poichè l'atto stesso di interpretare i dati "tradirebbe" l'autenticità dei dati stessi).
Dal punto di vista metodologico, in questo modo si tende a diffondere una concezione "binaria" della verità, secondo la quale i "fatti" sarebbero o del tutto veri, o del tutto falsi, senza possibilità intermedie.
La separazione dei "fatti" in categorie nette ("falso" da una parte, e "vero" dall'altra) è conseguenza dell'adozione di procedure binarie (tipiche degli algoritmi e delle procedure su cui si basano i programmi informatici) che tendono tuttavia a sovra-semplificare la natura complessa e multiforme della realtà.
Fact checking e la concezione manichea della verità
Per dirla in termini intuitivi, la verità quasi mai è tutta bianca (o nera) ma molto più spesso è "grigia" (e le sfumature non si limitano solo a "cinquanta", per parafrasare il titolo di un noto bestseller...).
La "Teoria della Verità Manifesta" è stata smentita in molte occasioni, e tra gli studiosi che più hanno contribuito a smanentirne la sostenibilità possiamo ricordare Karl Raimund Popper, divenuti famoso nel secolo scorso come filosofo della scienza proprio per aver proposto il suo "criterio di demarcazione" per distinguere le affermazione autenticamente scientifiche da quelle che non lo sono.
Secondo il criterio di demarcazione proposto da Popper, per poter validamente distinguere tra scienza autentica e pseudo-scienza è indispensabile utilizzare il principio di falsificazione, anzichè quello di verificazione.
In altri termini, per Popper un'affermazione può considerarsi scientifica solo se è possibile falsificarla, vale a dire se è possibile, in linea di principio, individuare anche un solo esempio che smentisca (invece di confermare) l'affermazione in questione.
La Ricerca non ha fine: il problema delle fonti
Uno degli aspetti insidiosi delle Fake News consiste proprio nel fatto che esse fanno affidamento su alcuni contenuti che sono caratterizzati da un certo grado di verosimiglianza (quando non addirittura su alcune verità consolidate, presentate però in maniera parziale e/o tendenziosa).
Le Fake News sono pericolose proprio perchè non sono smascherabili in maniera agevole
Le Fake News si alimentano spesso di "mezze verità", vale a dire verità parziali, che non tengono volutamente in conto di alcuni dettagli che le possano contraddire.
Non è pertanto sufficiente basarsi solo sul "fact checking" che faccia uso di procedure automatizzate per poter smentire le Fake News, ma occorre un lavoro continuo e sistematico di falsificazione (nel senso popperiano del termine) volto a separare costantemente nel tempo il contenuto "verosimile" da quello potenzialmente fuorviante (quando non addirittura "falso" in senso stretto).
Tale lavoro di falsificazione (come del resto il processo stesso di scoperta del nuovo tipico dell'impresa scientifica) non può essere dato per concluso una volta per tutte, in quanto nuovi fatti e nuove "conferme" (o smentite, se si preferisce) possono emergere con il tempo, che ci inducono a riconsiderare in maniera critica anche quegli stessi fatti considerati in precedenza come "assodati".
Per smascherare efficacemente le Fake News è più importante acquisire capacità critiche
È preferibile quindi assimilare le tecniche di ragionamento tipiche del Pensiero Critico (critical thinking), piuttosto che far ricorso a procedure "algoritmiche" che tendono a "semplificare" oltre misura la ricerca della verità dei fatti.
Semplificazioni binarie, buone per i computer ma non per la scienza
Per comprendere perchè l'approccio "binario" alla verifica dei fatti (che intende ridurre la realtà dei fatti in maniera netta, adottando la logica "vero/falso" tipica degli algoritmi utilizzati dai computer), possa dimostrarsi insufficiente, occorre analizzare l'elemento critico principale che caratterizza l'attività del fact checking, vale a dire il problema delle fonti di informazioni ritenute affidabili.
Quali fonti sono accettate come attendibili dai fact checkers?
L'enciclopedia online Wikipedia?
Oppure i risultati ottenuti tramite i motori di ricerca come Google?
Le fonti disponibili sul web sono da prefrire ai media tradizionali?
Il problema della affidabilità delle fonti è di fondamentale importanza nel processo di fact checking, in quanto se non si definiscono per prima cosa quali fonti di informazione si reputano affidabili, tutta l'attività di fact checking finisce per ridursi ad un circolo vizioso basato su una petizione di principio (vale a dire, è affetto da circolarità metolodologica che ne limita la validità logica delle conclusioni).